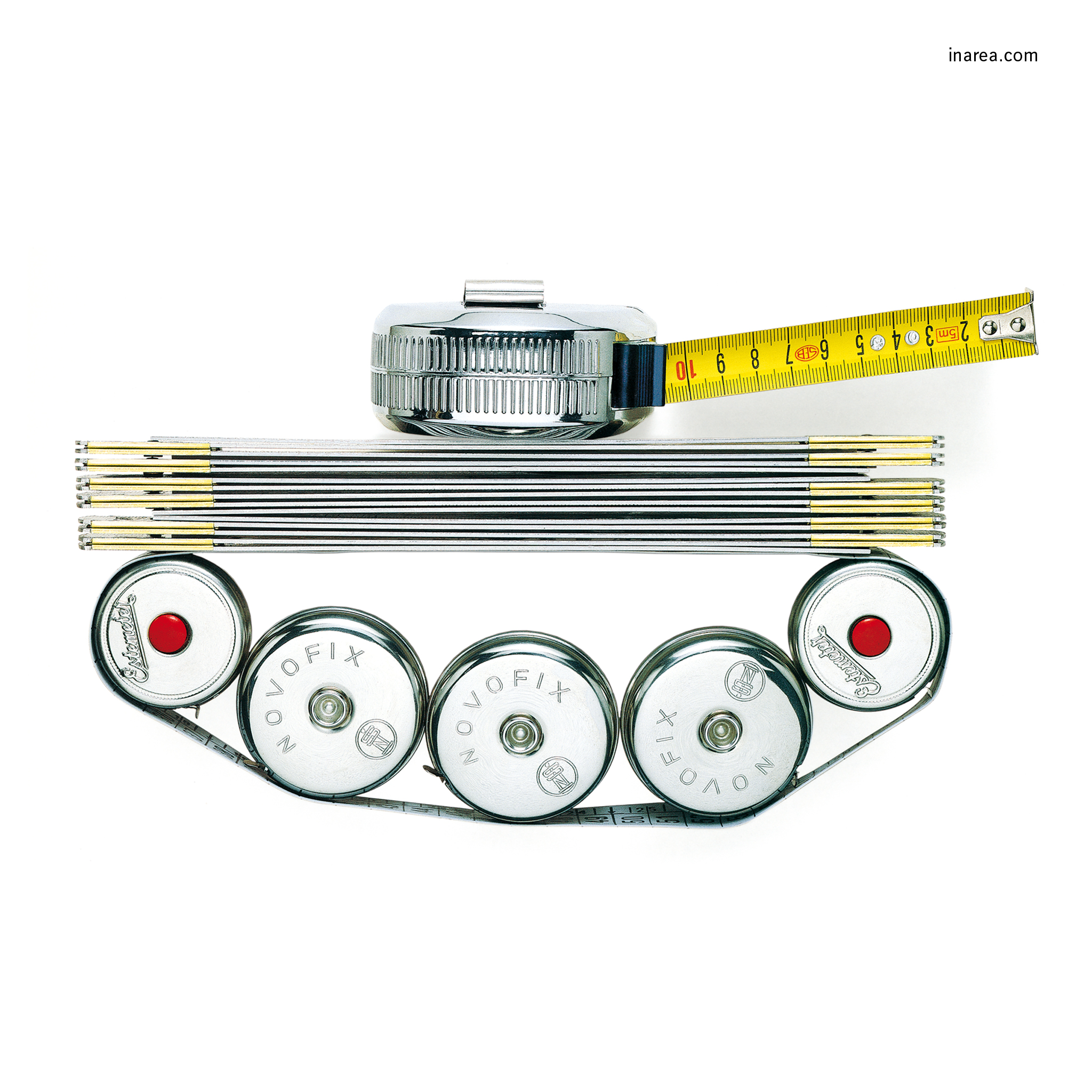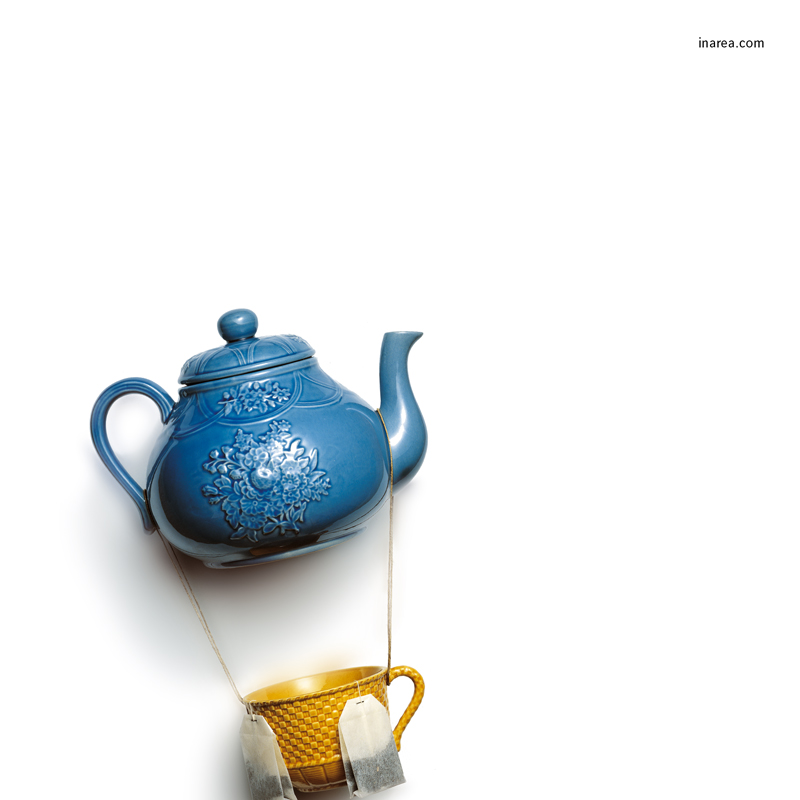Oggi raccontiamo una storia dove l’ottava è una piega e una nota. Siamo nel Rinascimento e a Magonza Gutenberg aveva già stampato la sua Bibbia. In Italia, precisamente a Venezia, c’era un tipografo affascinato dal design del messaggio; Aldo Manuzio creerà un modo di leggere che ancora non c’era, attirando a bottega i migliori artisti, incisori e anche filosofi, come Erasmo da Rotterdam. Dalle stamperie tedesche, infatti, uscivano libri sì moderni, ma per un tempo quasi andato: peso e dimensioni rendevano i volumi intrasportabili e poi quei filari di lettere così spessi facevano del carattere gotico non il migliore alleato dell’occhio. La stella polare di Manuzio era invece il formato: ispirerà il Garamond, un carattere così abile a nascondersi dietro le parole che, ancora oggi, è presente in molto di quello che vediamo stampato. Poi, sarà la volta del corsivo che si chiama Italics per merito suo e permette (tra gli altri vantaggi) di far entrare più lettere sulla carta. Tutto per arrivare all’ottavo, il foglio di carta piegato in 8 parti: il libro stava finalmente nel palmo della mano. Leggere in ogni dove significava aprire nuovi mondi: in fondo, si trattò di una rivoluzione paragonabile a quella che abbiamo vissuto quando il telefono, da fisso, è diventato mobile. Ad ogni modo, mezzo millennio dopo, la stampa sembra mossa ancora da questa parsimonia ispirata. Succede a un violino, ad esempio, progettato in 3D dalla facoltà di Architettura del Politecnico di Bari: si stampa in un giorno al costo di circa 100 euro (contro i 6 mesi di un liutaio e cifre ben oltre il migliaio). Nessuna competizione con il prodotto artigianale, semmai un invito a entrare nel mondo della musica in maniera semplice ed economica. Così come i libri di Manuzio, in qualche modo “tascabili”, resero più grande il mondo dei lettori. Cambierà l’approccio al suono? Chissà. La storia, però, ci dà qualche indicazione sull’importanza di essere sempre intonati ai tempi.