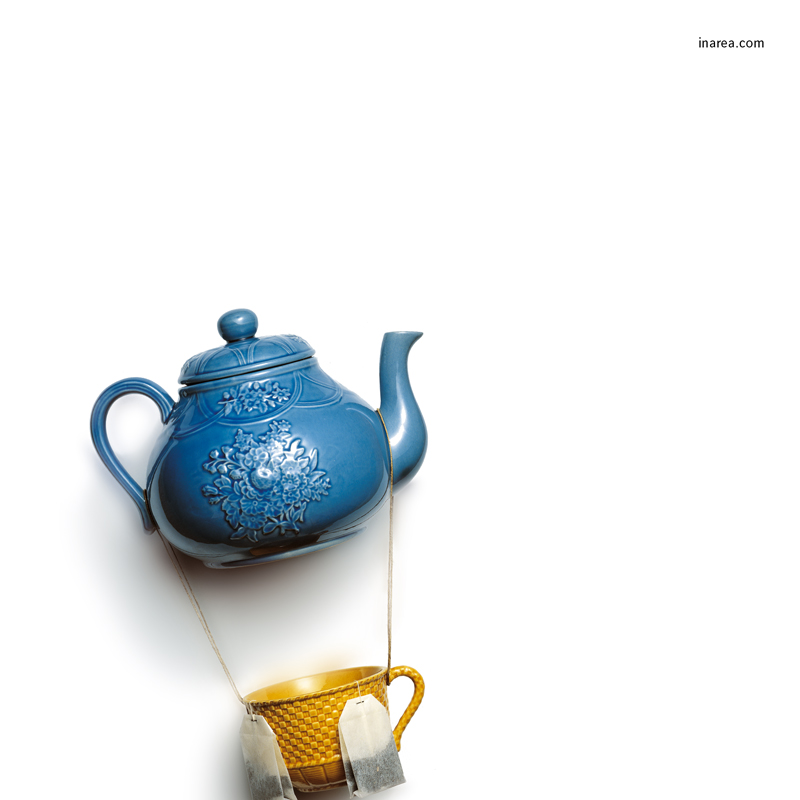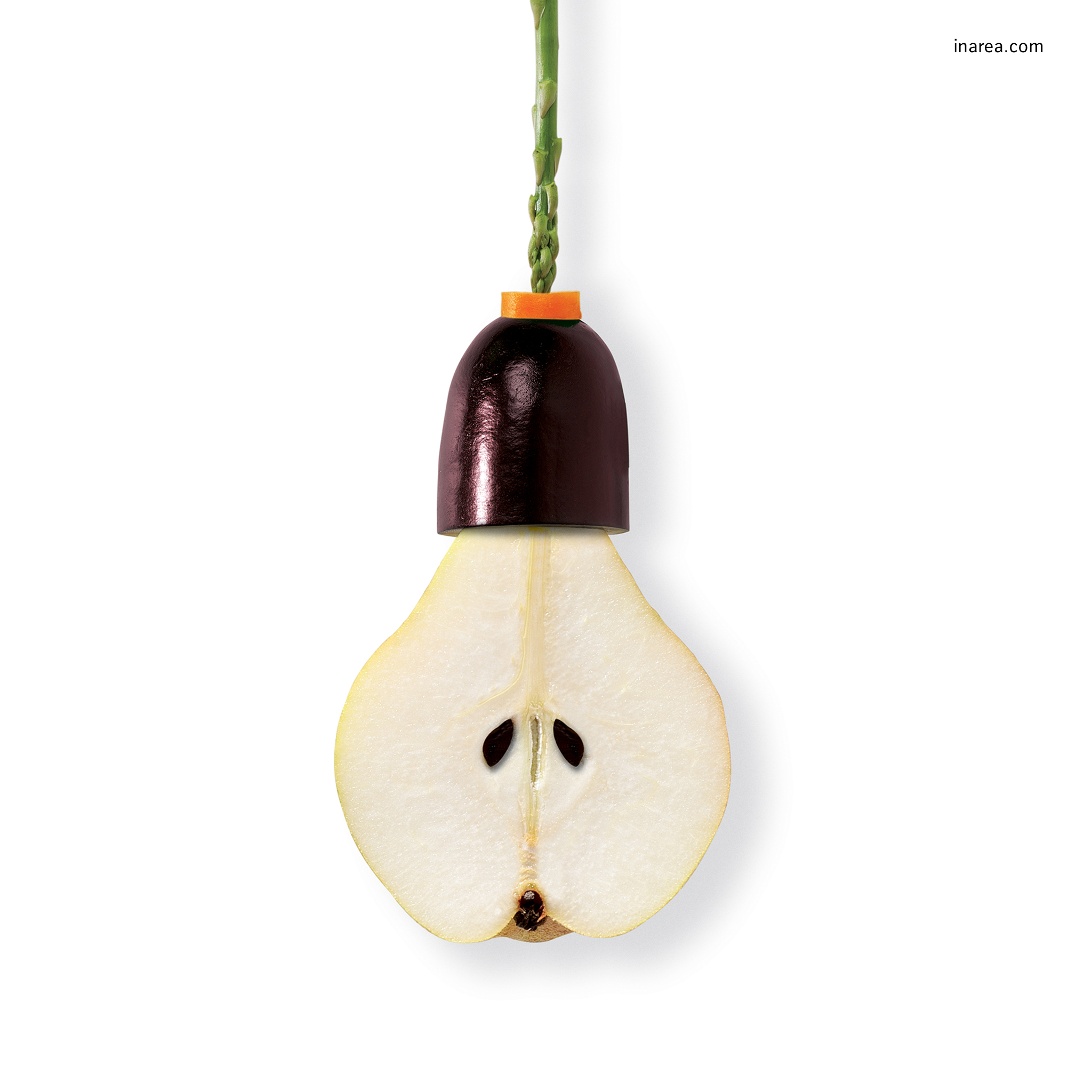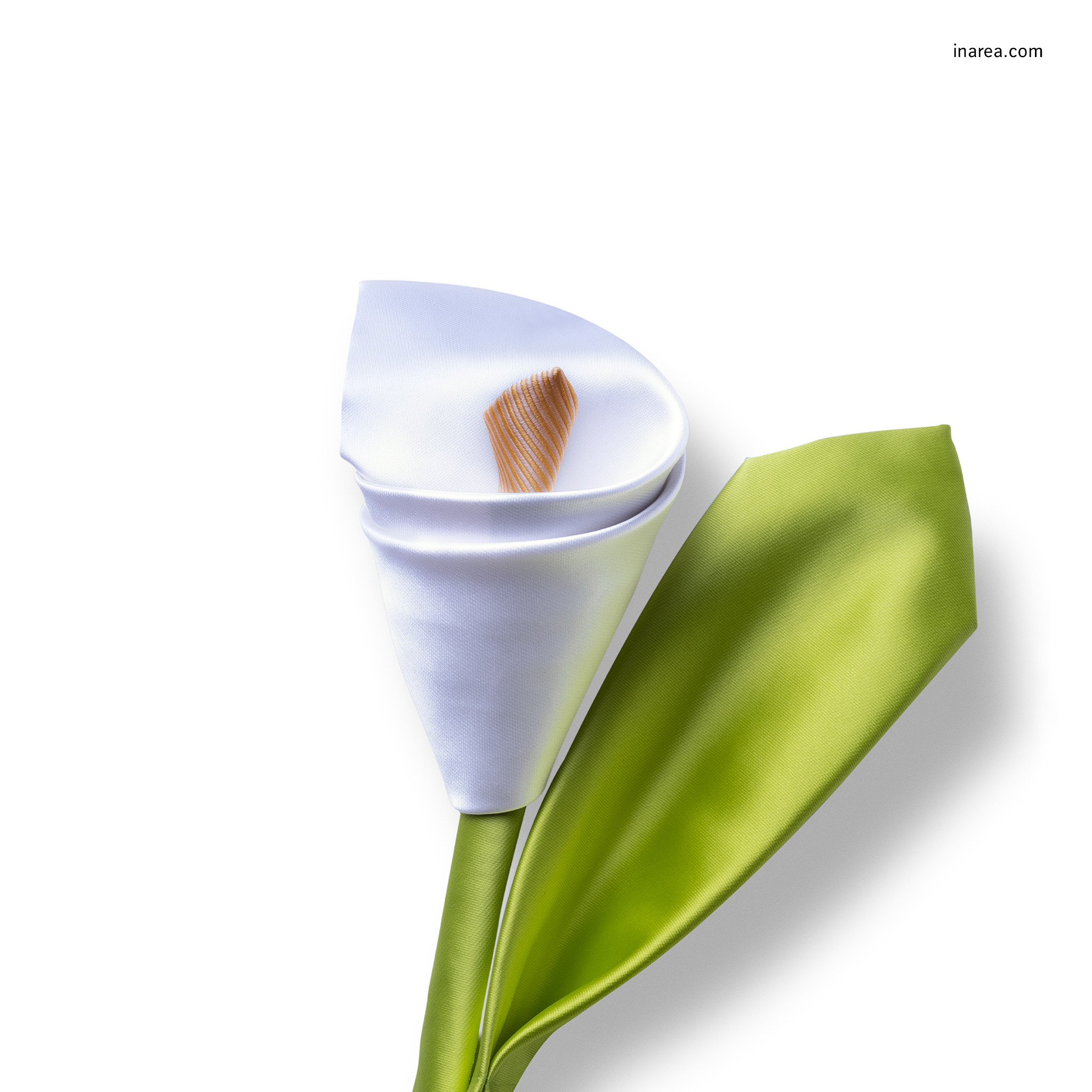Carlo Emilio Cracco
Trionfo di bufala del caseificio “Fienolento” di San Gregorio, su letto di misticanza e pomodorino IGP dell’azienda “Concime Ingrato”. Scherziamo un po’, ma deve esser capitato a molti di imbattersi in questo tipo di menù barocco. Quando arriva il piatto rimane però un certo minimalismo in bocca: in fondo si tratta di mozzarella su un po’ di insalata. Uno stile da cui sembrano prendere le distanze i cuochi stellati, premiati o confermati proprio in questi giorni dalla Guida Michelin 2023 con una, due o tre stelle. Sbocconcellano i piatti come fosse una formazione calcistica: “sogliola, lattuga e bergamotto”, “fieno e camomilla”. Ogni tanto fanno capolino un “assoluto di cipolle” o la “gallinella di mare ‘indecisa’”, ma in generale lo stile è secco; dobbiamo fidarci dei nostri condottieri. Effettivamente, negli ultimi anni ci sono stati presentati un po’ come i generali dell’abbattitore, al grido di comando di “EVO e prima qualità”. Ma non è solo colpa della televisione, il tutto arriva da più lontano. “Alla margarina dico no! E al burro che ha il sapore delle saponette: no!” questo era Carlo Emilio Gadda, nato come oggi nel 1893 e che non ammetteva deroghe all’“ufficio risottiero”. I cuochi lo sanno che c’è della comunicazione a monte di tutto questo rigore: fa allure e stile. Ma in fondo in fondo, sono altrettanto consapevoli che nel regime ordinato non c’è creazione (il panettone nasce da un errore). Per cui, ecco la nostra insalatina assemblarsi solo come fantasia comanda. Sicuri che a Gadda sarebbe parso un “pasticciaccio”: di Via Merulana no, sicuro di Casa Inarea.