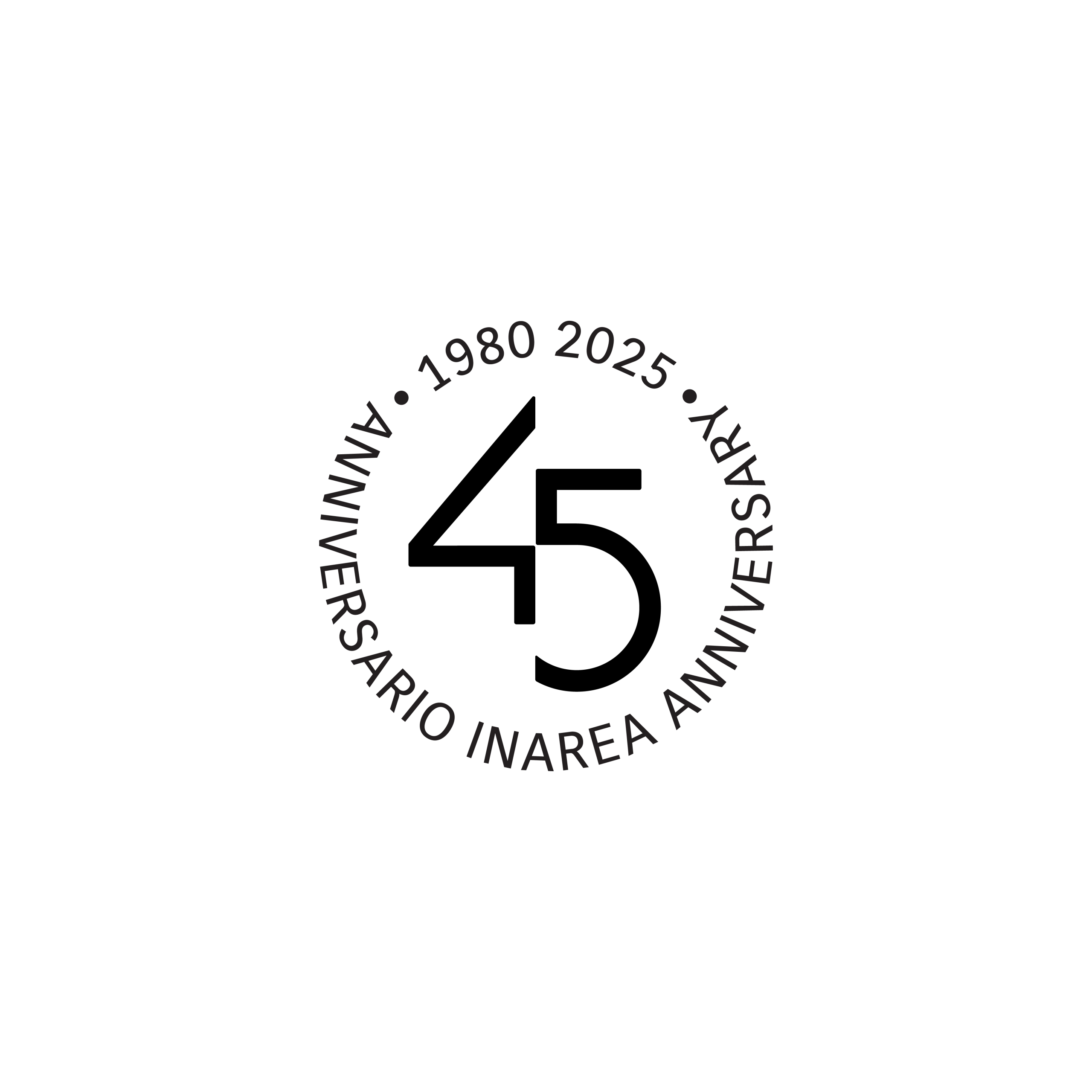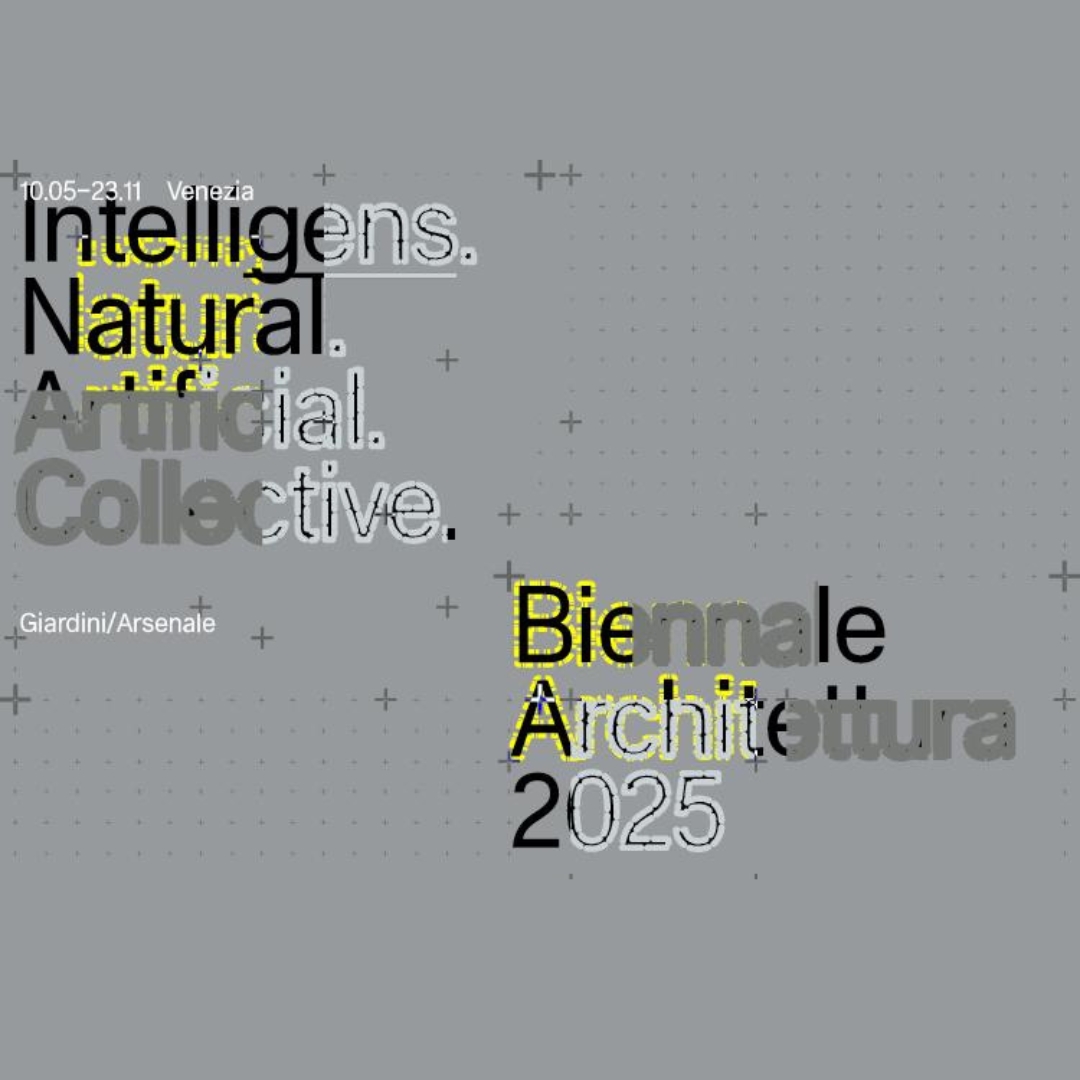Inarea: un design lungo 45 anni
I 45 anni di Inarea rappresentano un momento prezioso per guardarsi indietro e, al tempo stesso, immaginare il futuro. Anche se di solito sono i “compleanni con lo zero” a spingere alle riflessioni più profonde, questa tappa invita comunque a fare il punto sulla progettazione della brand identity, in un’epoca in cui design e comunicazione sono stati trasformati – tecnicamente e nei contenuti – come mai prima. Molte delle vecchie regole e degli strumenti di 45 anni fa non esistono più, ma i principi fondamentali, quelli “antichi quanto il mondo”, restano saldi. Antonio Romano, qual era l’ispirazione che ha guidato l’inizio del percorso? All’inizio ci muoveva il sogno del total design: l’idea di progettare “dal cucchiaio alla città”, dove il graphic design diventava un ponte tra discipline, un linguaggio universale per ogni forma di espressione. Questo ideale affonda le sue radici lontano nel tempo: pensiamo all’epoca dell’Araldo, che disegnava lo stemma del principe e lo declinava su tutto, architetture, uniformi e tessuti, creando un sistema simbolico di appartenenza in tempi di analfabetismo. In fondo, le logiche del branding non sono cambiate poi tanto. Anche oggi, pur in mezzo a una trasformazione tecnica e tecnologica enorme, i principi restano gli stessi. Negli ultimi decenni la comunicazione ha subito un’accelerazione impressionante. Con il digitale, cosa è cambiato di più nel concetto di branding? Gli anni ’80 erano l’epoca dell’esaltazione del visivo. Poi arrivano i ’90 con la telefonia mobile e Internet: una convergenza che cambia la storia dell’umanità. L’attenzione si sposta dall’araldica del prodotto a quella corporate, ma poi il passo ulteriore è stato la relazione: prodotti e servizi diventano esperienze, e la persona è al centro di tutto. Viviamo e lavoriamo in una dimensione digitale, uno spazio immateriale in cui trascorriamo gran parte del tempo attivo. I touchpoint fisici di un tempo sono stati integrati e spesso sostituiti da infinite interazioni online. La vera sfida oggi è costruire coerenza: nelle parole, nelle immagini, nei gesti digitali del brand, perché il giudizio dell’utente si forma in un istante e spesso è sommario e spietato. In un mondo così complesso e frammentato, qual è il principio fondamentale per creare un’identità di successo? Il principio che difendiamo è l’autenticità, cioè la base per rendere credibili e verificabili le affermazioni che un brand fa su sé stesso. Senza autenticità, il pubblico si allontana. Ciò si ottiene dalla convergenza di una trilogia: Purpose (il perché di ciò che fai), Process (il come lo fai) e People (le persone che lo rendono possibile, dentro e fuori l’organizzazione). Oggi la brand identity è sempre più multidimensionale e multisensoriale. Anche Inarea si muove in questa direzione? Certamente, il concetto di Brand Sense è per noi quasi un’ossessione. Ma in realtà non è affatto una novità. La Chiesa, per esempio, è maestra di branding: l’odore dell’incenso, la verticalità del campanile che domina la vista e diffonde il suono delle campane, l’atmosfera che unisce vista, olfatto e udito in un’unica esperienza (per non parlare della comunione, momento sublime della celebrazione, dove a essere coinvolto è anche il gusto). Persino l’architettura romanica nasce per rispondere alle esigenze di migliore propagazione del suono, in seguito all’introduzione dei canti gregoriani. Tutto questo insegna che, più un brand riesce a presidiare sensi diversi e a generare coerenza sinestetica, più forte e memorabile sarà il suo impatto. Come vi state preparando, in Inarea, alle “nozze d’oro”? Stiamo integrando competenze che un tempo delegavamo, soprattutto nel digitale, e ci stiamo aprendo all’Intelligenza Artificiale come strumento per amplificare velocità e profondità di contenuto. Il nostro mestiere impone di guardare sempre dalla prospettiva di chi ci osserva, degli stakeholder, ma la sostanza del valore identitario non cambia: vogliamo continuare a creare, attraverso il design, una comunicazione implicita e immediata, capace di generare impatto senza bisogno di spiegazioni – come diceva Oscar Wilde, “la bellezza ha il vantaggio sul genio di non dover essere spiegata”. Continueremo quindi a dare forma alla promessa di futuro restando una realtà ispirata sempre alla bottega rinascimentale, ma con un “brand corridor” in grado di orchestrare e coordinare in modo fluido le molteplici attività di comunicazione.